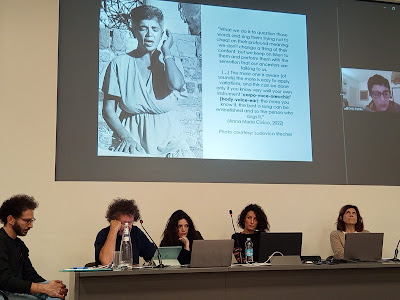Nel “De Sensu” Aristotele scrive che la vista ci fornisce una percezione immediata ma che solo l’udito può confermarla. Il lampo ci avvisa del temporale, il tuono lo conferma. Il tabellone della stazione ci informa sul nostro treno ma la voce dell’altoparlante ci rassicura. Due situazioni quotidiane di ascolto, la prima di tipo naturale, non antropico, la seconda di tipo tecnologico e antropico. Cosa possiamo imparare dall'ascolto della nostra casa comune in cui l’uomo non è che uno degli esseri viventi tra gli altri? Come progettarla, ripensarla e averne cura, alla luce (e al suono) delle attuali emergenze ambientali e non solo? Su questi interrogativi studiosi internazionali di varie discipline si sono confrontati per sei giorni, tre giorni online e tre giorni in presenza; i risultati delle discussioni sono ancora disponibili nel canale YouTube Redazione Musicheria. L’incontro è stato da organizzato da FKL, CSMDB, Tempo Reale e Università degli Studi di Firenze. Lo sfondo comune è stato l’aspetto educativo e pedagogico, per cui una delle istituzioni chiamata ad una sempre maggiore responsabilizzazione è stata la scuola.
Lunedì 25 novembre la sessione iniziale è stata coordinata da Alessandra Calanchi. Ad aprire è stato Mario Piatti con “Paesaggio sonoro come ‘Terzo Paradiso’”, proponendo un auspicato paradigma di convivenza tra il vecchio e il nuovo mondo sonoro ispirato alla famosa opera di Michelangelo Pistoletto. Artur Vidal ha raccontato le attività che propone ispirate alle Sonic Meditations di Pauline Oliveros e in particolare l’idea del fiume come fonte di meditazioni educative.
Sabine Feisst ha presentato “Paper Water Listening and Aquatic Soundscape Improvisation”, mentre Antonio Mastrogiacomo (Pedagogia e didattica dell’arte all’Accademia Belle Arti di Reggio Calabria) ha condiviso l’esperienza “A partire da RC soundscape”, utilizzando il centro di Reggio Calabria come laboratorio. Enrico Strobino ha ragionato della dimensione etica ed estetica in relazione ai paesaggi sonori e su come ascoltare e “riscrivere” il paesaggio sonoro con gruppi di preadolescenti. Strobino ha poi tenuto un sempre coinvolgente laboratorio nel pomeriggio di sabato. Emiliano Battistini ha raccontato “1, 2, 3… Ascolta!” Laboratorio di educazione all’ascolto per la scuola dell’infanzia ‘Tane sonore’ con bimbi 3-5 anni in cui i bimbi erano sia i ‘registrati’, sia ‘i registratori’ dell’esperienza sotto l’attenta osservazione delle ‘condotte’ del docente.
Martedì 26 novembre Roberto Pellizzoni ha condiviso il suo lavoro su “Ambienti, paesaggi sonori, paesaggi interiori: radici di una prospettiva sinestesica e multimodale” legato ad un approccio fenomenologico e al lavoro di Steve Feld sulla metafora. In particolare, ha analizzato una poesia di Montale.
All’inizio si è svolta una tavola rotonda con focus sui di bambini e le bambine di età fino a sei anni. Silvia Cornara, musicoterapeuta, ha proposto un’attività di paesaggio sonoro nel 2017-20 Asili Nido del Comune di Pisa dal titolo “Voci di spazi e tempo di voci”. Valeria Crescenzi ha presentato invece “I cambiamenti del paesaggio sonoro in TIN (terapia intensiva neonatale)”, informandoci su come “I suoni ci plasmano”. Gabriele Greggio ha proposto gli stimolanti “Paesaggi sonori brulicanti” fra paesaggi e espressioni artistiche attenzione al paesaggio sonoro all’interno dei nidi e delle scuole e all’invenzione sonora e musicale. Francesca Romana Motzo e Mara Lasi, hanno presentato “Musica in Bosco”, esplorazione natura, compresi ragni, insetti, invertebrati a Cagliari e dintorni. Ascoltare e riscrivere il paesaggio sonoro con gruppi di adolescenti è stato il tema affrontato da Maurizio Vitali con riferimento alle idee di Edgar Morin su ecologia e pensiero complesso. In particolare, ha presentato un Laboratorio di Soundscape improvisation che ha coinvolto 80 alunni e alunne che hanno pensato ai paesaggi sonori come teatri educativi) e come occasioni per affinare l’ascolto, pensando alla didattica dell’improvvisazione in funzione dello sviluppo di capacità di ascolto attivo e profondo. Il percorso legato all’improvvisazione ha privilegiato un piccolo bosco vicino alla scuola. Le prime attività sono state orientate all’ascolto della sonosfera ispirata da Janet Cardiff. Il primo percorso ha identificato tre luoghi e proposto due passeggiate, invitando chi partecipava a realizzare prima registrazione e poi a ripercorrere il sentiero con cuffie “aperte” giocando coi volumi/potenziometri, un modo di andare indietro nel tempo; la seconda proposta ha invitato chi partecipava a creare partiture con strumenti, sorta di sonorami in cui l’umano sceglie di essere presente con i propri strumenti, sollecitando un approccio delicato e atteggiamento di cura della sonosfera. La proposta teorica ha trovato poi riscontro nel laboratorio tenuto dallo stesso Vitali nel pomeriggio di sabato 30, dando vita a stimolanti improvvisazioni tenute prima all’esterno e poi all’interno dell’Istituto Marconi che scaturito profonde e sentite riflessioni nei partecipanti.
Tags:
I Luoghi della Musica