 Ci sono proposte musicali che fortunatamente mantengono intatta una propria dose di personalità. In quello che è il mare magno della musica Salentina e della indiscriminata riproposta di suoni a base di tamburelli, c’è chi della propria cultura esalta gli aspetti meno commerciali. Dario Muci, è un artista che è sempre stato attento alle vie traverse della musica tradizionale, approfondendo i repertori legati alla polivocalità (suo il lavoro di ricerca sul repertorio delle sorelle Gaballo di Nardò) ed alla musica strumentale e colta di tradizione. Il suo nuovissimo “Rutulì” spazia fra il repertorio strumentale cosiddetto “da barberìa”, ovvero la musica colta che veniva suonata nelle sale da barba, e quello vocale Salentino. Inutile ripetere l’importanza di straordinari alberi di canto come il gruppo di Cutrofiano Gli Ucci, Antonio Bandello, Antonio Aloisi e Leonardo Vergaro; In “Rutulì” l’ispirazione principale è il repertorio degli Ucci, dei quali Dario Muci riprende riarrangiandolo con gusto estremamente personale e moderno, il patrimonio di “canzoni” alcune delle quali contenute in edizione originale nel disco di Uccio Bandello, “La voce della tradizione”. Abbiamo incontrato Dario Muci, per farci raccontare la genesi di questo nuovo lavoro, soffermandoci tanto sulla ricerca quanto sulle figure che lo hanno ispirato.
Ci sono proposte musicali che fortunatamente mantengono intatta una propria dose di personalità. In quello che è il mare magno della musica Salentina e della indiscriminata riproposta di suoni a base di tamburelli, c’è chi della propria cultura esalta gli aspetti meno commerciali. Dario Muci, è un artista che è sempre stato attento alle vie traverse della musica tradizionale, approfondendo i repertori legati alla polivocalità (suo il lavoro di ricerca sul repertorio delle sorelle Gaballo di Nardò) ed alla musica strumentale e colta di tradizione. Il suo nuovissimo “Rutulì” spazia fra il repertorio strumentale cosiddetto “da barberìa”, ovvero la musica colta che veniva suonata nelle sale da barba, e quello vocale Salentino. Inutile ripetere l’importanza di straordinari alberi di canto come il gruppo di Cutrofiano Gli Ucci, Antonio Bandello, Antonio Aloisi e Leonardo Vergaro; In “Rutulì” l’ispirazione principale è il repertorio degli Ucci, dei quali Dario Muci riprende riarrangiandolo con gusto estremamente personale e moderno, il patrimonio di “canzoni” alcune delle quali contenute in edizione originale nel disco di Uccio Bandello, “La voce della tradizione”. Abbiamo incontrato Dario Muci, per farci raccontare la genesi di questo nuovo lavoro, soffermandoci tanto sulla ricerca quanto sulle figure che lo hanno ispirato.
Rutulì è un termine dialettale che non ha un significato. Foneticamente da il senso di qualcosa che ruota e nello stesso tempo è il titolo di un canto tradizionale presente nell’album. Ho scelto questo titolo sia perché fa parte del repertorio degli “Ucci, a cui ho dedicato il lavoro, e sia perché ha un suono frizzante e giocoso, come lu curru (trottola ripresa nell’immagine di copertina)
“Rutulì” viene pubblicato a due anni di distanza da “Sulu”. Cosa è successo a Dario Muci in questi due anni?
Il mio obbiettivo è quello di cercare di riproporre le diverse espressioni musicali che appartengono alla cultura tradizionale del Salento. Per questo ho lavorato tanto sulla pizzica (Salentorkestra, Officina Zoè), sul canto polivocale (Sorelle Gaballo), sul canto di protesta (Sulu), sulla sperimentazione (Mayis-Mandatari) arrivando alla barberìa e al repertorio dei canti narrativi (Rutulì). A volte mi è capitato di cantare delle canzoni senza conoscerne la provenienza e la loro storia; a memoria, così come le ho acquisite. Poi, scopro che hanno più di duecento anni e alcune sono ancora più vecchie. Questo è successo in questi anni. Una passione per il repertorio tradizionale ancora più forte che mi ha immobilizzato e che fa continuare il mio percorso di riproposta, per sensibilizzare i salentini e il pubblico della canzone popolare all’ascolto di nuovi repertori, messi da parte dalla spettacolarizzazione della tradizione.
 I brani contenuti in questo nuovo lavoro sono (contrariamente a quelli in “Sulu”) tutti salentini.
O per meglio dire, versioni salentine di brani ampiamente diffusi nel territorio nazionale.
Ti va di parlarne brano per brano ?
I brani contenuti in questo nuovo lavoro sono (contrariamente a quelli in “Sulu”) tutti salentini.
O per meglio dire, versioni salentine di brani ampiamente diffusi nel territorio nazionale.
Ti va di parlarne brano per brano ?
I canti di questo disco, completamente rivisitati, mantengono le linee originali eseguite dai cantori di Cutrofiano, con delle variazioni introdotte in fase di arrangiamento. Ai classici salentini più famosi come “Rutulì” e “Ninella mia de Calimera” seguono brani come “Costantino”, un canto che risale alle guerre del risorgimento, gli alpini la conoscono come la “Portantina che porti quel morto”o “La licenza del soldato”. “Giulia”, un canto presente in alcune regioni del nord, una particolare versione è quella della Maremma Grossetana; il brano si presenta incompleto, a differenza di altri ritrovamenti, a tratti con una totale mancanza di senso. “La barca di Roma”, anche questo di provenienza settentrionale, richiama le migrazioni di fine '800 inizi '900 per l'America; alcune sue strofe, con piccole variazioni di testo, le ritroviamo in un canto toscano dal titolo “Son sonate”. “La vena dell’amor” (detta anche “Cava più giù signore dottore”), sulla scia dell’ “Uccellin de la comare”, si presenta sempre malizioso e anche se la struttura melodica e il soggetto sono diversi, rimangono le allusioni nei versi, tipica ricostruzione di molti testi con dichiarazione di desiderio amoroso. “La figlia dell’oste”, una romanza risalente molto probabilmente al primo concilio vaticano; alcuni clerici vaganti, diretti a Roma, inventavano melodie e racconti per intrattenere la gente in modo da poter ripagare l’ospitalità. “Nunna nunna”, un canto che molti contadini del Salento avevano ascoltato durante la loro permanenza lavorativa in Basilicata e in Campania. Naturalmente non mancano i ballabili: una polka e una mazurca, brani che appartengono al repertorio suonato nelle sale da barba (saloni). Fino alla metà degli anni ’50, molti barbieri erano suonatori di strumenti a corda, un retaggio derivato probabilmente dalla presenza spagnola nei secoli passati. Negli intervalli vuoti, durante la settimana, svolgevano attività musicale e chiunque poteva apprendere lo studio di uno strumento: chitarra, mandolino, violino, erano i più usati. I maestri di livello musicale più alto formavano gruppi strumentali in grado di eseguire brani classici proposti in “serate musicali” di vario tipo. Ai barbieri erano affidate, inoltre, le serenate (omaggi musicali notturni fatti dedicare dall’uomo alla donna amata). La maggior parte dei brani cantati nel disco sono stati arrangiati dal maestro Calsolaro in chiave classica, ispirandosi alla barberìa e alla musica d’epoca (notturni, barcarole), un altra forma musicale che i barbieri conoscevano benissimo per la riproposta negli ambienti più raffinati.
 Come ti spieghi il totale disinteresse per quella che è una delle forme artistiche più diffuse in Salento fino a qualche decennio fa? Intendo il repertorio di canti mono e polivocali rispetto alla dilagante moda della pizzica.
Come ti spieghi il totale disinteresse per quella che è una delle forme artistiche più diffuse in Salento fino a qualche decennio fa? Intendo il repertorio di canti mono e polivocali rispetto alla dilagante moda della pizzica.
Secondo me il progresso e successivamente l’abbandono della vita agro pastorale ha portato la fine dei repertori prevalentemente vocali. Basti pensare che si cantava mentre si infilava il tabacco, mentre si raccoglievano le olive, il grano, mentre si pescava. Il canto era presente ovunque perché attraverso lo stesso la gente dimenticava per un attimo la consapevolezza della loro condizione sociale, dando un ritmo al loro lavoro. Nel frattempo la “pizzica” diventa la nostra identità musicale che ci contraddistingue per ritmo, passione e sangue. La gente, nel mondo e in Italia, ci riconosce per la pizzica, non per il canto polivocale, la barberìa o altre forme di espressioni musicale. Naturalmente, oltre a questo mi rendo conto che, a differenza del terzinato irruento e liberatorio del tamburo sul canto, i canti mono e polivocali hanno una struttura armonica ridotta e monotona che quasi annoia lo spettatore abituato all’ascolto di repertori più trascinanti. Il disinteresse per questa tipologia di repertori, se vogliamo, è venuto a mancare già in passato, dopo la ricerca di Ernesto de Martino. Tutti gli studiosi sono venuti in Salento principalmente per il fenomeno tarantismo, limitando, se non annullando del tutto, la ricerca successiva. A parte qualche eccezione (ricercatori locali e Giovanna Marini) la ricerca non è andata oltre al rito terapeutico più conosciuto e studiato nel Mediterraneo: la pizzica. Ma questo è solo un mio punto di vista.
Come nasce la collaborazione con il maestro Calsolaro, che abbiamo visto accanto all'ultima formazione di Uccio Aloisi?
Il maestro Antonio Calsolaro lo conosco da quando suonava con Uccio. L’estate scorsa mentre ero impegnato in alcune sessioni di registrazioni sul campo, andai a trovarlo ad Alessano per delle interviste. Dopo la prima, seconda, terza intervista gli parlai di questo nuovo progetto. Gli sembrò una bellissima idea e si mise a lavorare da subito. Antonio è molto affezionato a me e mi dice spesso del bene che mi voleva Uccio Aloisi.
Importantissimo direi. Mi hanno insegnato il canto polivocale salentino ed infiniti cunti e storie della mia zona e grazie a loro posso permettermi di portare avanti e raccontare, agli altri, come si canta a “paraoce”(o alla stisa). Naturalmente per arrivare a questo c’è stata un’assidua frequentazione nelle loro case , addirittura le incontravo tre volte alla settimana. Alla fine anche loro, dopo tanto tempo che non praticavano il canto, hanno raggiunto un’ armonizzazione da lasciarti incantato. Ora ho in mente di pubblicare un altro lavoro su di loro; il primo disco s’intitola “Sorelle Gaballo – canti polivocali del Salento Nardò – Arneo” ed. Kurumuny.
Hai un ricordo del maestro Stifani che vorresti condividere?
Ricordi c’è ne sono tanti…, ma non dimenticherò mai come l’ho conosciuto. Non avevo nemmeno vent’anni, non esisteva la Notte della Taranta e non sapevo nulla di questa musica se non qualche canto che mi ricordo in campagna del nonno materno. Passeggiavo a Santa Maria e fui completamente rapito dal suono di un violino; era lui, con un amplificatore semi funzionante che si esibiva sulla piazza del paese. Rimasi lì ad ascoltarlo e si alternava con la chitarra cantando brani mai sentiti prima, del tipo la “canzone delle massare”,” Lu monacu”, “La veste”, ecc. Poi riprendeva il violino e prima di suonarlo raccontava delle tarantate. E’ stato in quel momento che scoperto la mia musica, la musica tradizionale del Salento. Da lì fino alla sua morte (28 giugno del 2000) l’ho sempre accompagnato. E anche questa storia di abbandonarci il giorno di San Paolo (protettore dei tarantolati) non la capirò mai.
 Leggevo che la presentazione di “Rutulì” è avvenuta a Tuglie, con l'intenzione di ridare vita alla festa di S. Maria Goretti ed in un quartiere ormai quasi abbandonato. Da dove viene questa necessità di ritornare al passato e riappropriarsi degli spazi vicini?
Leggevo che la presentazione di “Rutulì” è avvenuta a Tuglie, con l'intenzione di ridare vita alla festa di S. Maria Goretti ed in un quartiere ormai quasi abbandonato. Da dove viene questa necessità di ritornare al passato e riappropriarsi degli spazi vicini?
Il mio amico Antonio Vincenti, organizzatore di un premio importante in Salento “Che cà Canta Storie”, mi voleva a Tuglie per questo evento e mi raccontò il perché. Purtroppo alcune feste dei rioni o dei piccoli paesi non si fanno più per diversi motivi legati alla politica, alla mancanza di soldi, al disinteressamento delle amministrazioni locali, ecc. Fino a pochi anni fa, in questo piccolo rione di Tuglie si alternavano i gruppi più importanti della scena musicale tradizionale: Uccio Aloisi, Cantori di Carpino, Teresa de Sio, Pino Zimba, Officina Zoè, ecc. Ad un tratto non si fece più nulla e la festa di Santa Maria Goretti, con la perdita anche di Don Dante (fautore dell’ iniziativa), non si fece più fino alla presentazione del mio ultimo disco, “Rutulì”. Abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo, in mezzo alla strada, come si faceva una volta e alle spalle la masseria Aragona e la chiesa di San Girolamo del 1600, ormai ridotte al totale abbandono. Tutto questo naturalmente per pura e semplice provocazione, denunciando a nostro modo l’abbandono e il disinteresse delle nostre bellezze architettoniche e paesaggistiche.
Come vedi il futuro per la musica di tradizione salentina?
È evidente un certo calo rispetto agli anni scorsi, anche una specie di stanchezza dovuta al boom e alla rinascita che in questi vent’anni passati hanno fatto conoscere ancora di più il Salento nel mondo. Prevedo un futuro incerto per la musica tradizionale per una serie di motivazioni: Per prima cosa, scompaiono tutti gli alberi di canto, cioè tutti quei cantori e cantrici che potrebbero ancora rivelarci nuovi repertori. Secondo, la nuova riproposta è impegnata più all’aspetto spettacolare della tradizione che alla costruzione di progetti, anche nuovi, ma che facciano convivere il nuovo e il vecchio; Terzo, non c’è stata mai la cultura dell’ascolto, ma solo l’aspetto trascinante dei soliti repertori composti prevalentemente dalle stesse pizziche rifatte in chiave diverse, per accontentare gli organizzatori delle sagre e di altri contenitori culturali; Infine, troppi soldi investiti per l’organizzazione di eventi d’estate mentre d’inverno si muore. Dovrebbe essere un po’ più equilibrata la distribuzione delle risorse, anche perché il Salento è un vero museo aperto tutto l’anno… e quante altre cose potrei aggiungere che influiscono sul futuro della musica tradizionale salentina!
 Domanda provocatoria. Ritieni che quella che suoni sia ancora "musica di tradizione" ? Quando una musica smette di essere patrimonio tradizionale?
Domanda provocatoria. Ritieni che quella che suoni sia ancora "musica di tradizione" ? Quando una musica smette di essere patrimonio tradizionale?
Credo di si! Sono e mi definiscono un cantore , nuovo, giovane, ma tradizionale. Anche gli “Ucci” negli anni ‘60, seppure trascinati dalla radio, dalla televisione e da altri generi musicali, a giudicare dalle registrazioni che ci sono pervenute, hanno sempre mantenuto una linea tradizionale tanto da essere ritenuti da tutti I cantori di Cutrofiano. Secondo me, una musica smette di essere patrimonio tradizionale quando si rompe il legame con le radici, ormai avvelenate dal business e dalla poca cultura popolare e quando si spaccia per tradizionale, una musica frutto solo di spettacolo, non trasmessa oralmente. Mi è capitato di registrare degli anziani che si sono avvicinati a me solo perché hanno saputo in giro che c’era un giovane musicista che ricercava i canti tradizionali. In Salento ormai la confusione impera dietro questi repertori e alcuni, specialmente anziani, hanno capito come guadagnarsi un po’ di fama e magari diventare i nuovi Ucci o semplicemente i cantori per eccezione di un paesino qualsiasi. Poi scopro che è tutto un bluff e dalle interviste riesco a capire che questi signori non conoscono affatto il repertorio tradizionale (sicuramente l’avranno sentito nelle campagne), ma cantano versioni nuove, ascoltate dalle nuove pubblicazioni dei gruppi di riproposta o addirittura dai repertori che hanno ascoltato nei quindici anni di Notte della Taranta.
Francesco Patruno
Dario Muci – Rutulì (Lupo Editore, 2013)
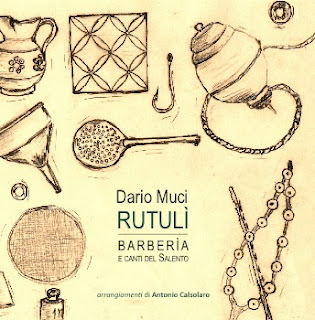 Musicista e ricercatore, dotato di rara sensibilità musicale, Dario Muci nel corso della sua carriera ha unito una intensa attività musicale dal vivo ed in studio, ad un personale percorso di ricerca che lo ha portato dapprima a collaborare con figure storiche della tradizione salentina come Luigi Stifani, il violinista delle tarantate, e successivamente a dedicarsi a numerose ricerche sul campo, tra cui spicca il pregevole lavoro dedicato ai canti polivocali delle Sorelle Gaballo. Tale peculiare approccio con la musica tradizionale, unito ad una immensa dose di passione e curiosità gli ha consentito negli anni di ampliare il suo repertorio, rubando dall’oblio vere perle del corpus di canti salentino. Il suo nuovo album “Rutulì”, che giunge a due anni di distanza dall’ottimo “Sulu”, rappresenta così un altro passaggio importate della sua carriera, mescolando brani dal repertorio degli Ucci, con quello del repertorio delle Barberie Salentine, legato alla mitica figura di Stifani. Fino agli anni cinquanta le sale da barba erano uno dei luoghi principali della musica salentina, durante la settimana infatti i barbieri spesso imbracciavano gli strumenti e insieme ad altri musicisti non professionisti si esibivano in un ampio repertorio di brani che spaziava dalle musiche da ballo alle arie delle opere liriche. Non è un caso che una delle figure più importanti della musica tradizionale salentina sia stato un barbiere musicista come il già citato Luigi Stifani, che fu l’ultimo grande suonatore del tarantismo. Ad accompagnare Dario Muci in questo nuovo lavoro discografico troviamo un eccellente gruppo di musicisti in cui spicca il mandolinista ed arrangiatore Antonio Calsolaro, già negli ultimi anni musicista nel gruppu di Uccio Aloisi, il suo allievo e collaboratore Massimiliano de Marco (chitarra), Vito de Lorenzi (tamburi del Salento), Roberta Mazzotta (violino), Rocco Nigro (fisarmonica), Marco Bardoscia (contrabbasso), Andrea Doremi (tuba), Giancarlo Paglialunga (voce), Antonio Castrignanò (voce), Claudio “Cavallo” Giagnotti (voce), Cosimo Giagnotti (voce). Durante l’ascolto spiccano non solo i classici della tradizione salentina, come le trascinanti “Rotulì” e “Ninella Mia De Calimera” ma anche brani meno noti come “La Vena Dell’Amor” e alcuni canti in italiano, provenienti dal repertorio appreso dagli informatori durante la loro esperienza di guerra al fronte (“Costantino”), tuttavia il vertice del disco lo si tocca tanto con la “Polka” e la “Mazurka”, che ci giungono direttamente dal repertorio delle “barberìe”, quanto con lo splendido e toccante canto d’amore “Nunna Nunna”. Insomma “Rutulì” è un bel disco realizzato con intelligenza ed originalità nel quale la ricerca sulle fonti tradizionali è diventata la base per lo sviluppo di un idea concettuale per nulla scontata, che mira a gettare nuova luce su un repertorio poco noto al grande pubblico, quale quello delle barberìe salentine.
Musicista e ricercatore, dotato di rara sensibilità musicale, Dario Muci nel corso della sua carriera ha unito una intensa attività musicale dal vivo ed in studio, ad un personale percorso di ricerca che lo ha portato dapprima a collaborare con figure storiche della tradizione salentina come Luigi Stifani, il violinista delle tarantate, e successivamente a dedicarsi a numerose ricerche sul campo, tra cui spicca il pregevole lavoro dedicato ai canti polivocali delle Sorelle Gaballo. Tale peculiare approccio con la musica tradizionale, unito ad una immensa dose di passione e curiosità gli ha consentito negli anni di ampliare il suo repertorio, rubando dall’oblio vere perle del corpus di canti salentino. Il suo nuovo album “Rutulì”, che giunge a due anni di distanza dall’ottimo “Sulu”, rappresenta così un altro passaggio importate della sua carriera, mescolando brani dal repertorio degli Ucci, con quello del repertorio delle Barberie Salentine, legato alla mitica figura di Stifani. Fino agli anni cinquanta le sale da barba erano uno dei luoghi principali della musica salentina, durante la settimana infatti i barbieri spesso imbracciavano gli strumenti e insieme ad altri musicisti non professionisti si esibivano in un ampio repertorio di brani che spaziava dalle musiche da ballo alle arie delle opere liriche. Non è un caso che una delle figure più importanti della musica tradizionale salentina sia stato un barbiere musicista come il già citato Luigi Stifani, che fu l’ultimo grande suonatore del tarantismo. Ad accompagnare Dario Muci in questo nuovo lavoro discografico troviamo un eccellente gruppo di musicisti in cui spicca il mandolinista ed arrangiatore Antonio Calsolaro, già negli ultimi anni musicista nel gruppu di Uccio Aloisi, il suo allievo e collaboratore Massimiliano de Marco (chitarra), Vito de Lorenzi (tamburi del Salento), Roberta Mazzotta (violino), Rocco Nigro (fisarmonica), Marco Bardoscia (contrabbasso), Andrea Doremi (tuba), Giancarlo Paglialunga (voce), Antonio Castrignanò (voce), Claudio “Cavallo” Giagnotti (voce), Cosimo Giagnotti (voce). Durante l’ascolto spiccano non solo i classici della tradizione salentina, come le trascinanti “Rotulì” e “Ninella Mia De Calimera” ma anche brani meno noti come “La Vena Dell’Amor” e alcuni canti in italiano, provenienti dal repertorio appreso dagli informatori durante la loro esperienza di guerra al fronte (“Costantino”), tuttavia il vertice del disco lo si tocca tanto con la “Polka” e la “Mazurka”, che ci giungono direttamente dal repertorio delle “barberìe”, quanto con lo splendido e toccante canto d’amore “Nunna Nunna”. Insomma “Rutulì” è un bel disco realizzato con intelligenza ed originalità nel quale la ricerca sulle fonti tradizionali è diventata la base per lo sviluppo di un idea concettuale per nulla scontata, che mira a gettare nuova luce su un repertorio poco noto al grande pubblico, quale quello delle barberìe salentine.
Salvatore Esposito
Tags:
Salento


