Come hai costruito la partitura? Come avete operato le scelte insieme ad Ambrogio Sparagna, che cofirma il film?
La scelta è stata fatta insieme ad Ambrogio Sparagna. Originariamente avrei voluto lavorare sul Sud , magari anche sul Centro, ma Ambrogio mi ha fatto capire subito che andava raccontato – pur nelle diversità tra Nord, Centro e Sud – come un unicum.
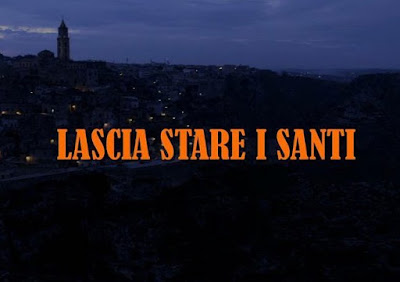 C’è stato un punto di riferimento importante come quello del viaggio di Alan Lomax e Diego Carpitella, che attraversarono buona parte dell’Italia raccogliendo la cultura popolare-musicale, la cultura di tradizione orale prima del boom economico e dell’industrializzazione. È stato un modello importante; ci siamo detti: «Per noi il Nord e il Sud possono sembrare molto diversi, ma tutto ciò come è avvertito da un americano e da un tedesco?» Nel Sud c’è qualcosa di ancestrale e il culto dei santi è più forte più, ma al Nord esistono delle sacche di resistenza importanti, da rimettere in gioco, da riproporre.
C’è stato un punto di riferimento importante come quello del viaggio di Alan Lomax e Diego Carpitella, che attraversarono buona parte dell’Italia raccogliendo la cultura popolare-musicale, la cultura di tradizione orale prima del boom economico e dell’industrializzazione. È stato un modello importante; ci siamo detti: «Per noi il Nord e il Sud possono sembrare molto diversi, ma tutto ciò come è avvertito da un americano e da un tedesco?» Nel Sud c’è qualcosa di ancestrale e il culto dei santi è più forte più, ma al Nord esistono delle sacche di resistenza importanti, da rimettere in gioco, da riproporre.
Quali storie ti hanno preso di più nella ritualità italiana? Prima hai citato il culto di San Domenico di Cocullo, qualcosa lo avevi già documentato in altri lavori, come la festa di Madonna Avvocata su a Maiori…
Sono molto legato alla festa della Madonna dell’Avvocata. Fu una grande sorpresa la prima volta salire su in cima e trovare una sorta di campeggio… medievale, dove la gente si stabilisce per alcuni giorni, dove convivono delinquenti, frati e centri sociali. Una differenza tra Nord e Sud è che in una città come Napoli, che oltre a San Gennaro vanta tantissimi altri patroni, parlare di santi è abbastanza normale. Invece, al nord la reazione è molto particolare: come di qualcosa che si era dimenticato, ma che, dopotutto, è restato dentro.
 Interessante è stata anche la reazione dei laici, di chi non sente l’appartenenza religiosa o il bisogno del sacro. La “Madonna Avvocata” è un unicum, non lo può trovare se non in certe parti della Puglia o in Sicilia. Un’altra festa che mi è rimasta impressa è quella di Sant’Agata a Catania perché è molto sentita. Lo scorso anno siamo capitati durante la premessa della festa, che comincia due settimane prima. Non è solo per il colore, che è la parte più superficiale, ma è per come è sentita, specialmente dai giovani: è qualcosa di molto forte. Lì c’è il fenomeno dei giovani che ritornano per festeggiare, che arrivano dieci giorni prima per partecipare alla festa. Resto molto sorpreso dal fatto che, contrariamente alla vulgata, c’è un forte sentire di queste feste, forse anche più intenso perché c’è l’elemento intellettuale, la possibilità di scappare e tornare che non c’era prima. Dice Ambrogio che questo sentire è frutto del fatto che la gente, credente o non credente, avverte la presenza di una comunità che si mette in moto; c’è uno spirito del vivere insieme l’esperienza, cosa che in questo mondo di monadi cui apparteniamo è abbastanza rara. Forse è anche colpa della politica che non riesce ad aggregare come faceva un tempo. Quindi la religione è vissuta in un modo che mi sembra interessante. Mi piace anche ricordare come sono vissute certe feste in Sardegna. Gramsci dice a sua madre: «Tu sei lontana da me, ma io dipendo da te». Io sono ateo, non credente, ma tutto quello che mi hai trasmesso rimane in me. Secondo me c’è qualcosa di importante, che fa parte della consapevolezza della persona, una consapevolezza che evidentemente non appartiene a tutti, ma che si risveglia quando porto in giro il film. Che piaccia o meno, il film risveglia nelle coscienze qualcosa di ancestrale, legata alla pancia: ho visto professori in lacrime, laici di sinistra, agnostici in lacrime, questa è una cosa che mi ha molto colpito.
Interessante è stata anche la reazione dei laici, di chi non sente l’appartenenza religiosa o il bisogno del sacro. La “Madonna Avvocata” è un unicum, non lo può trovare se non in certe parti della Puglia o in Sicilia. Un’altra festa che mi è rimasta impressa è quella di Sant’Agata a Catania perché è molto sentita. Lo scorso anno siamo capitati durante la premessa della festa, che comincia due settimane prima. Non è solo per il colore, che è la parte più superficiale, ma è per come è sentita, specialmente dai giovani: è qualcosa di molto forte. Lì c’è il fenomeno dei giovani che ritornano per festeggiare, che arrivano dieci giorni prima per partecipare alla festa. Resto molto sorpreso dal fatto che, contrariamente alla vulgata, c’è un forte sentire di queste feste, forse anche più intenso perché c’è l’elemento intellettuale, la possibilità di scappare e tornare che non c’era prima. Dice Ambrogio che questo sentire è frutto del fatto che la gente, credente o non credente, avverte la presenza di una comunità che si mette in moto; c’è uno spirito del vivere insieme l’esperienza, cosa che in questo mondo di monadi cui apparteniamo è abbastanza rara. Forse è anche colpa della politica che non riesce ad aggregare come faceva un tempo. Quindi la religione è vissuta in un modo che mi sembra interessante. Mi piace anche ricordare come sono vissute certe feste in Sardegna. Gramsci dice a sua madre: «Tu sei lontana da me, ma io dipendo da te». Io sono ateo, non credente, ma tutto quello che mi hai trasmesso rimane in me. Secondo me c’è qualcosa di importante, che fa parte della consapevolezza della persona, una consapevolezza che evidentemente non appartiene a tutti, ma che si risveglia quando porto in giro il film. Che piaccia o meno, il film risveglia nelle coscienze qualcosa di ancestrale, legata alla pancia: ho visto professori in lacrime, laici di sinistra, agnostici in lacrime, questa è una cosa che mi ha molto colpito.L’aspetto fonico è centrale in film di questo tipo. E poi il suono, la musica che un notevole potere narrante…
 Insieme ad Ambrogio ho scelto meno testi, lavorando più sulle musiche. C’è un viaggio, un lavoro musicale che andava fatto, una musicalità che ha condizionato anche il montaggio del film. Il film doveva essere pregno di questa musica, lasciando però degli spazi di silenzio, di apertura. Al primo montaggio avevamo riempito il film di musiche, poi siamo riusciti ad allargare, togliendo alcuni brani. È un film che vive di musica, che è un collante importante. Sant’Agostino diceva: “Chi canta prega due volte”. La musica è un conforto, un modo per stare insieme, condividere l’esperienza. Questa musica condiziona tutto il film, creando anche un continuum nella diversità. Per esempio i canti femminili, molto frequenti, che accompagnano il nord come il sud. I canti di dolore, che però hanno una loro dolcezza dolorosa. Esiste questa Italia dolorosa che riesce ad esprimere nel dolore una dolcezza, specie attraverso il canto femminile. Penso al canto in Basilicata di Caterina Pontrandolfo, ma anche ai canti del Nord: “Gesù bambin l’è nato” di Maddalena Scagnelli. Insomma, c’è un denominatore comune, che passa attraverso questa sorta di pietas cattolico- cristiana che accompagna tutta l’Italia e che abbiamo cercato di portare dentro il film.
Insieme ad Ambrogio ho scelto meno testi, lavorando più sulle musiche. C’è un viaggio, un lavoro musicale che andava fatto, una musicalità che ha condizionato anche il montaggio del film. Il film doveva essere pregno di questa musica, lasciando però degli spazi di silenzio, di apertura. Al primo montaggio avevamo riempito il film di musiche, poi siamo riusciti ad allargare, togliendo alcuni brani. È un film che vive di musica, che è un collante importante. Sant’Agostino diceva: “Chi canta prega due volte”. La musica è un conforto, un modo per stare insieme, condividere l’esperienza. Questa musica condiziona tutto il film, creando anche un continuum nella diversità. Per esempio i canti femminili, molto frequenti, che accompagnano il nord come il sud. I canti di dolore, che però hanno una loro dolcezza dolorosa. Esiste questa Italia dolorosa che riesce ad esprimere nel dolore una dolcezza, specie attraverso il canto femminile. Penso al canto in Basilicata di Caterina Pontrandolfo, ma anche ai canti del Nord: “Gesù bambin l’è nato” di Maddalena Scagnelli. Insomma, c’è un denominatore comune, che passa attraverso questa sorta di pietas cattolico- cristiana che accompagna tutta l’Italia e che abbiamo cercato di portare dentro il film.
Tra le voci che recitano brani d’autore, ci sono Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni...
 Sono persone che hanno un rapporto molto sano con lo spettacolo e con il teatro molto. Investono nel corpo e nella loro voce con coraggio e con forza, con i monologhi, rimettendo in scena la letteratura: basti pensare quanto sia legato Gifuni a Gadda o allo stesso Pasolini. Mi piace molto il loro lavoro sul corpo e sulla voce. In questo caso è stato un lavoro di voce. Ho pensato fossero le persone più giuste per poter capire lo spirito del film. Tra l’altro, c’è un loro legame forte anche con Sparagna. Quindi c’è stata anche questa bella coincidenza.
Sono persone che hanno un rapporto molto sano con lo spettacolo e con il teatro molto. Investono nel corpo e nella loro voce con coraggio e con forza, con i monologhi, rimettendo in scena la letteratura: basti pensare quanto sia legato Gifuni a Gadda o allo stesso Pasolini. Mi piace molto il loro lavoro sul corpo e sulla voce. In questo caso è stato un lavoro di voce. Ho pensato fossero le persone più giuste per poter capire lo spirito del film. Tra l’altro, c’è un loro legame forte anche con Sparagna. Quindi c’è stata anche questa bella coincidenza.
Come ti rapporti con il cinema del reale? Come considerare gli aspetti etici sul piano sia della ripresa che del significato?
È una dialettica interessante perché io sono legato al cinema del reale, lo sguardo antropologico è importante, lo sguardo ad altezza d’uomo, il non giudicare, ma anche l’immergersi nel mondo, per poi intrepretarlo. Rivendico al documentario qualcosa di più: non basta solo lo sguardo osservazionale, non mi piace quello interventivo, però ritengo che lo sguardo partecipato sia molto importante. Per sguardo partecipato intendo qualcosa che inerisce non solo al sentirsi parte di una comunità, seppure fuori dalla comunità dei nativi. Significa anche rivendicare a sé un intervento creativo, uno sguardo d’autore, una riconoscibilità.
 Più che seguire in forme di cinema diretto la realtà, è più importante lavorare su un’evocazione: ecco perché ho trovato molto congeniale, molto divertente fare un film come “Lascia stare i santi”, perché era un film che mi permetteva di rafforzare lo sguardo più poetico ed evocativo – cosa che avevo già cominciato un po’ con “Sul Vulcano” – che in questo momento mi interessa di più di quello squisitamente narrativo. Anche nel film che sto facendo adesso, che si chiama “Mondo Za”, dedicato alla Bassa emiliana, dove è il Po della Bassa, dove è nato Zavattini al confine con la Lombardia, ho privilegiato questo sguardo evocativo, anche rielaborando delle musiche di Händel in chiave popolare con la fisarmonica. Sempre il rapporto tra alto e basso, ma è una chiave anche spiazzante: è più importante il basso o l’alto? No, è importante trasmettere un’emozione. La realtà non può più essere solo più riprodotta, perché restituita dal regista-antropologo, la realtà va interpretata anche in una chiave in qualche modo poetica. Allora, il film è come se fosse diventato, in montaggio, un lavoro di nuovo presente, non è né passato né presente, ma una specie di presente storico. Questo presente storico lo considero molto più importante dello stare sul qui e ora e della registrazione. È un qualcosa che investe anche tutto il dibattito su antropologia e cinema; penso alla polemica con gli antropologi visuali: “Dò la telecamera al nativo che si riprende…”.
Più che seguire in forme di cinema diretto la realtà, è più importante lavorare su un’evocazione: ecco perché ho trovato molto congeniale, molto divertente fare un film come “Lascia stare i santi”, perché era un film che mi permetteva di rafforzare lo sguardo più poetico ed evocativo – cosa che avevo già cominciato un po’ con “Sul Vulcano” – che in questo momento mi interessa di più di quello squisitamente narrativo. Anche nel film che sto facendo adesso, che si chiama “Mondo Za”, dedicato alla Bassa emiliana, dove è il Po della Bassa, dove è nato Zavattini al confine con la Lombardia, ho privilegiato questo sguardo evocativo, anche rielaborando delle musiche di Händel in chiave popolare con la fisarmonica. Sempre il rapporto tra alto e basso, ma è una chiave anche spiazzante: è più importante il basso o l’alto? No, è importante trasmettere un’emozione. La realtà non può più essere solo più riprodotta, perché restituita dal regista-antropologo, la realtà va interpretata anche in una chiave in qualche modo poetica. Allora, il film è come se fosse diventato, in montaggio, un lavoro di nuovo presente, non è né passato né presente, ma una specie di presente storico. Questo presente storico lo considero molto più importante dello stare sul qui e ora e della registrazione. È un qualcosa che investe anche tutto il dibattito su antropologia e cinema; penso alla polemica con gli antropologi visuali: “Dò la telecamera al nativo che si riprende…”.  Sono decisamente contro questo aspetto e rivendico lo sguardo dell’autore e la capacità dell’autore di mettersi in gioco attraverso il linguaggio, anche a costo di essere provocatorio rispetto a quel mondo popolate o musicale.
Sono decisamente contro questo aspetto e rivendico lo sguardo dell’autore e la capacità dell’autore di mettersi in gioco attraverso il linguaggio, anche a costo di essere provocatorio rispetto a quel mondo popolate o musicale.
Parlando di musica, cosa ascolta Gianfranco Pannone?
Ascolto di tutto, dalla musica popolare di tradizione orale (primo naturalmente Ambrogio Sparagna con i suoi musicisti) al jazz, dal rock d’annata ai mai tramontati cantautori italiani, dalla musica classica fino ad alcuni fenomeni italiani e stranieri della nuova scena musicale che mi indica mia figlia Costanza, di quasi sedici anni; per esempio lo Stato Sociale o Calcutta. Amo avanti a tutti Paolo Conte. Ascolto i concerti di Rachmaninov e con grande trasporto, sono un fan di Lou Reed e seguo da sempre alcuni grandi interpreti come Paul Hannon o Uter Lemper o David Sylvian. Quasi dimenticavo! Ho un debole per Lelio Luttazzi, Mina e Charles Aznavour. E certo non lascio fuori un interprete eclettico e geniale come Stefano Bollani. Ultimo ma non ultimo, l’immenso Nino Rota.
Proviamo a stilare la tua playlist di musica italiana, tra tradizione orale e nuove musiche di ispirazione tradizionale?
In ordine sparso: Francesco De Gregori e Giovanna Marini del CD “Il fischio del vapore”, le antiche canzoni napoletane interpretate ad arte dalla mai tramontata Nuova Compagnia di Canto Popolare, i canti e le danze per tammorra di musicisti (e amici) del calibro di Gianni Aversano, Margaret Ianuario e Daniele Barone (Damadakà, ndr), i grandi ‘alberi di canto’ del Sud: da Otello Profazio a Rosa Balestreri, le canzoni apulo-salentine dei Ghetonìa, in particolare “Ninusu ninusu”, l’eclettismo del miglior Daniele Sepe, quando incontra le voci e i suoni della musica popolare del nostro Sud. Gabriella Ferri del “Valzer della toppa” di Pasolini. Infine, come dimenticare l’insuperabile festa della musica di Giuseppe Morandi e del Micio nell’annuale festa della Lega di Cultura a Piadena?
Ciro De Rosa
La Playlist di Gianfranco Pannone
Tags:
Visioni
